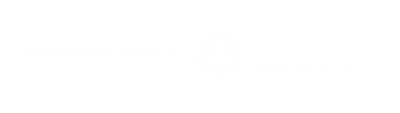Questo, in sintesi, il contenuto del principio di diritto enunciato nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25698 depositata lo scorso primo settembre.
Nella fattispecie analizzata dalla Corte, un contribuente italiano titolare di una partecipazione non qualificata in una partnership statunitense aveva, dapprima, indicato nella propria dichiarazione l’utile da partecipazione da essa derivante quale reddito assoggettato ad imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 18 del TUIR, per poi compensare quest’ultima con l’imposta pagata sullo stesso reddito negli Stati Uniti.
Ai sensi della normativa domestica (art. 165 del TUIR), il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero – quale rimedio per risolvere i casi doppia imposizione – viene riconosciuto a condizione che gli stessi concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente.
I redditi di capitale percepiti per il tramite in un intermediario residente sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, senza quindi concorrere al reddito complessivo. Ugualmente, per i redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente, l’art. 18, co.1 del TUIR prevede l’assoggettamento ad imposta sostitutiva in sede di dichiarazione, salvo la possibilità di far concorrere il reddito alla base imponibile e accedere così al credito d’imposta. Possibilità espressamente esclusa, tuttavia, per quei redditi di capitale che siano utili societari.
In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni lo scenario sembrerebbe mutare drasticamente. L’art. 23, co. 3 della Convenzione Italia- Stati Uniti (clausole dello stesso tenore sono presenti in gran parte delle convenzioni esistenti, con significative eccezioni) prevede, infatti, che l’Italia consenta la deduzione delle imposte pagate negli Stati Uniti; tuttavia, “nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana”.
Facendo leva sulla locuzione “su richiesta del beneficiario” e in virtù di un principio di sovra-ordinazione della norma pattizia – laddove più favorevole – rispetto a quella domestica, la Corte di Cassazione ne ha fatto discendere che laddove non vi sia facoltà di scelta, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria in luogo dell’imposta sostitutiva (così come nel caso degli utili di fonte estera di cui all’art. 18), l’imposta estera deve considerarsi detraibile.
La sentenza in commento si presenta di notevole interesse per i seguenti aspetti.
In primo luogo, la pronuncia in commento parrebbe smentire la posizione consolidata della Agenzia delle Entrate (da ultimo principio di diritto n.14/2019), secondo cui vi sarebbe una esatta coincidenza tra i requisiti convenzionali e domestici di spettanza del foreign tax credit.
Il principio di diritto commentato – almeno in alcuni casi – parrebbe proporre una soluzione volta a mitigare la doppia imposizione degli utili societari di fonte estera, laddove percepiti direttamente dal contribuente persona fisica e come tali non rientranti nell’ambito applicativo del cd. regime del “netto-frontiera”.
Infine, la sentenza ha il pregio di chiarire l’indirizzo interpretativo da seguire nei confronti di alcune tra le più recenti Convenzioni stipulate dall’Italia, laddove alla locuzione “su richiesta del contribuente” sia stata aggiunta la congiunzione “anche”[1]. Più nel dettaglio, la Corte ha affermato che in tali situazioni l’Italia ha inteso negare il credito d’imposta anche quando l’assoggettamento ad imposta sostitutiva di un reddito sia obbligatorio.
[1] Cfr. Convenzioni contro le doppie imposizioni tra Italia e Principato di Monaco o Singapore.